Cadere verso l’alto
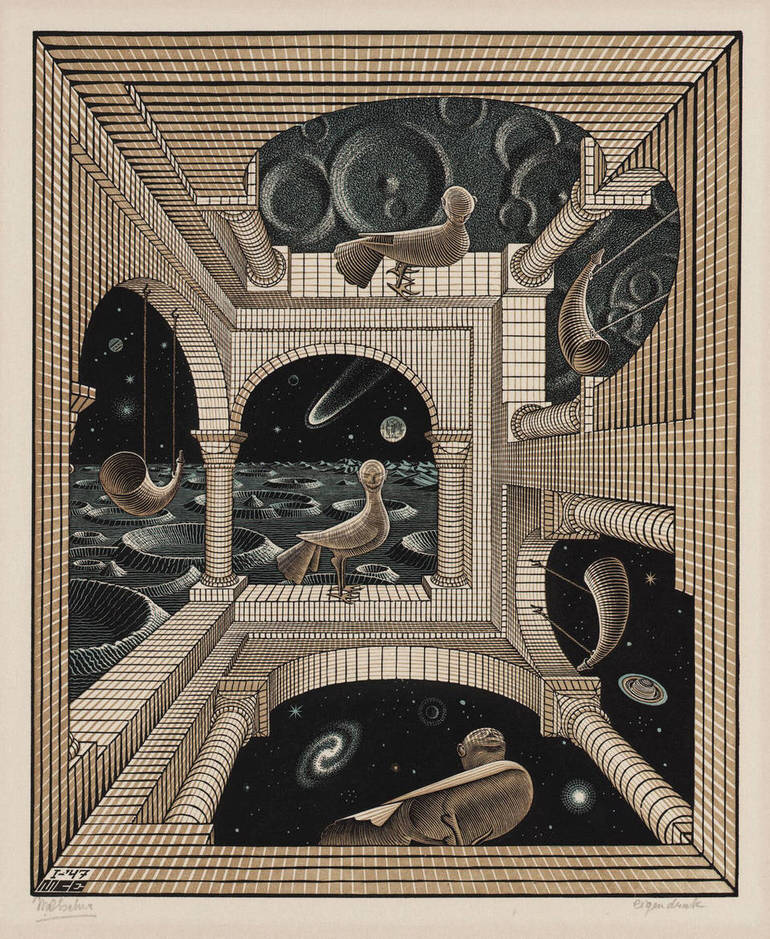
Articolo di Christine Gruwez, pubblicato in Das Goetheanum (30 settembre 2022)
Cari amici,
la grande traversata delle Notti Sante ci ha condotto nel nuovo anno, che salutiamo insieme con un gentile inchino. A guidarci in questo gesto sono le recenti riflessioni di Christine Gruwez, che qui condividiamo in traduzione augurando a tutti voi un buon inizio nel 2023.
Un mondo basato sull’antichissima antitesi di luce e tenebra potrebbe forse peccare di troppa bidimensionalità: se abbiamo il coraggio di esplorare la dimensione della profondità, si apriranno davanti a noi nuovi campi di indagine. Nel dominio della forza di gravità, della pesantezza, si avventurò il pensiero di Simone Weil – e su quel sentiero si trovano anche le tracce di Rudolf Steiner.
È possibile una discesa agli inferi con la forza di un moto ascendente?
Buona lettura!
Alessandra Coretti
La forza di gravità è la legge della Terra, è la legge della realizzazione e del peso. Gli uomini che sanno portare con delicatezza il proprio essere ferito trasformano la pesantezza in Grazia.
Questa mattina molto presto, lungo la via verso la stazione [Bahnhof] – il luogo della rivelazione –, ho visto alcuni uomini africani: all’alba aspettavano in silenzio sul ciglio della strada che qualcuno li venisse a prendere per portarli a raccogliere la frutta. Ho spostato subito il mio sguardo dall’altra parte della strada, perché non riuscivo a trovare in me sufficiente forza di carità. Perché io stessa sono stata ferita dalla loro vulnerabilità così manifesta, e non ero in grado di portare questa ferita. La loro ferita, non la mia.
Molte persone, per i più diversi motivi, vivono l’attuale situazione del mondo come un tempo “pesante”. C’è molto che opprime e che grava. E in una misura tale che le forze per sostenerlo non sono più sufficienti. Sembra ci sia sempre di meno a sostenerci, come se fosse aumentata l’intensità della forza di gravità. In momenti del genere si rivela la vulnerabilità del nostro essere umani. Si rivela proprio nel punto in cui siamo più vulnerabili, lì dove c’è un rapporto vivente. È la relazione tra tutti gli esseri viventi che costituisce il potenziale fondamento della nostra storia sulla Terra – una storia che c’è soltanto se possiamo condividerla gli uni con gli altri in questo senso. Un rapporto vivente non è una relazione già data o prestabilita, non è un collegamento in cui le regole del gioco siano già state definite. Non è un sistema. Una relazione va fondata [gestift], sempre di nuovo, in ogni momento. Si tratta di un fatto. Soltanto il singolo può creare [stiften] da se stesso una relazione; solo mediante il suo agire questa relazione può proseguire.
Quando questo nesso vivente non può più manifestarsi – sia in forma di idea operante, sia come possibilità di azione, o in ambedue i casi – oggi ci troviamo di fronte a un problema. L’immane complessità che si manifesta nella gara tra i diversi ambiti di crisi si oppone alla rivelazione di un rapporto vivente. E non per via del rapporto, bensì per ciò che è vivente.
La paura si diffonde da un’angoscia esistenziale, dal bisogno di potere e dalla pressione a risolvere tale complessità, o almeno a dipanarla. L’autodifesa, la protezione, il tracciamento di confini non sono altro che strategie per mantenere o per riconquistare il controllo sulle proprie cose e sui loro proprietari.
Di fronte a questo un rapporto vivente può infrangersi. Si sgretola in tanti pezzi, si frantuma in una riproduzione di sé che si espande senza limite, diventa un universo di astrazioni in rete. Di fronte a ciò molti esseri umani soccombono. Lì si infrange l’essenza umana in noi.
Quando viene a mancare la relazione vivente, ci si ritrova nel freddo di un’anonima indifferenza, di un involucro vuoto che non contiene alcuna interiorità, perché è pura superficie. Quello è il luogo della più grande vulnerabilità. E al contempo è il luogo in cui diventa chiaro che soltanto lì, dove siamo vulnerabili, può destarsi nuovamente il senso di umanità in ciascuno di noi.

Am Anfang war das Wort
Al principio della forza creatrice
La vita, qui intesa come “relazione vivente”, viene definita da Rudolf Steiner come principio creatore. Principio significa: ciò che da sé è in grado di dare avvio a una dinamica, a un processo in movimento che si realizza nel corso del tempo. In una conferenza dedicata al Manicheismo, Steiner descrive il principio della vita in diretta relazione con il principio della forma. (1) Due princìpi, dunque, dalla cui costante interazione nel corso del tempo può venir generato un elemento nuovo. Il nuovo non si manifesta tutto d’un tratto, non è una forma definitiva, bensì assume nel corso del tempo un aspetto che è costantemente mutevole, una forma legata al tempo. Ciò che si svolge è l’interazione tra i due princìpi. Da una parte opera il principio della vita, che contiene in sé la possibilità di assumere forma. Questa potenza [Potenz] porta in sé l’intenzione di dotarsi di una forma. A tal scopo, il principio della vita ha bisogno che sia efficace il principio della forma. Entrambi i princìpi sono ugualmente creatori, benché il loro effetto sia diametralmente opposto. La forma argina la potenza creatrice della vita che da sé si sprigiona, la limita e le offre la necessaria resistenza. Soltanto quando questi due princìpi si incontrano si può parlare di relazione.
La vita, quando viene intesa quale principio creatore, non corrisponde alla “biòs”, cioè alla vita naturale. Quest’ultima ci è stata infatti assegnata, e non abbiamo preso parte alla sua creazione. La vita come potenza, come pura facoltà, può invece realizzarsi solo in un movimento che imprime forma e che scaturisce da me. Chiedersi quale sia la causa di questo movimento può soltanto deviarci su moventi esteriori; la causa reale di questo moto si trova invece dentro di me, lì dove riesco a trattenermi un momento alla sorgente della mia forza creatrice. Non soltanto io sono all’origine, io sono nell’origine. Io sono in me.
Io sono in me lì dove sono vulnerabile. Lì, dove posso divenire attivo in modo creatore.
Derubati del presente
«In alcune grandi città in Europa quest’estate delle persone dormivano per strada. Dormivano davanti a un edificio, la cui porta si sarebbe aperta solo alle nove del mattino dopo. Hanno dormito lì per tutta l’estate. Quando arrivava la sera, si sedevano su un pezzo di cartone o su alcuni sacchetti di plastica e aspettavano finché scendeva la notte per potersi distendere. Alla prima luce del giorno si rimettevano di nuovo in fila per non perdere il proprio posto. La porta si apriva. Iniziava un rituale che si ripeteva ogni giorno. Venivano chiamati i loro nomi, i nomi che avevano scritto su un foglietto al momento della registrazione. A volte erano circa due o trecento. Il numero di quelli chiamati raramente superava la ventina. Nella calca e nel clamore – c’erano anche bambini – non era facile capire correttamente già alla prima chiamata. Spesso un nome suonava in modo del tutto diverso, come estraneo. Era forse il mio nome? Ogni giorno questo tesissimo, esasperato stare in ascolto – e se fosse stavolta? Stare in ascolto, senza potersi permettere di pensare ad altro anche solo per un momento, per non dire poi di rivolgere la parola a uno degli altri. Non soltanto uno non riceve nessun accesso allo spazio lì fuori, ma gli viene portato via anche il tempo. Condannati solo a continuare ad aspettare se si sente il proprio nome». (2)
Quello che leggo suona come una scena da un dramma misteriosofico. In L’ombra e la grazia <titolo originale: La pesanteur et la grâce> (*) Simone Weil menziona situazioni simili in Europa – dove in moltissimi aspettavano che venisse chiamato il loro nome –, immagini del più grande enigma dell’esistenza umana. È la situazione in cui ogni essere umano nasce sulla Terra, completamente esposto. Un essere esposti non come condizione che si genera per mezzo degli ingranaggi della Storia o mediante gli interessi del potere politico, bensì come una parte intrinseca alla natura dell’essere, propria di ogni singolo uomo: il mistero dell’incarnazione. Io sono vulnerabile sulla base del mio stesso essere. È il punto in cui ogni essere umano già dalla nascita porta una ferita. Ogni essere umano nasce completamente inerme. Da neonato è in balìa di un insieme di azioni che non è in grado di compiere da sé: non può infatti né svezzarsi, né mantenersi caldo né difendersi da solo.
Proprio questo è ciò che Simone Weil definisce “l’infelicità” («le malheur»), e paragona con la schiavitù questa situazione di esposizione totale all’arbitrio di una volontà estranea: «Perché la subordinazione all’arbitrio è schiavitù? La causa ultima risiede nel rapporto fra l’anima e il tempo. Colui che è sottoposto all’arbitrario è sospeso al filo del tempo; attende (è la situazione più umiliante) quel che l’istante seguente gli porterà. Non dispone dei suoi istanti; il presente per lui non è più una leva che agisce sull’avvenire». (3) Simone Weil concepisce dolore e sofferenza (“la souffrance”) come conseguenze di questa vulnerabilità primordiale, di questa ferita con la quale ogni essere umano viene al mondo.
Due forze regnano sull’universo
«La pesantezza fa discendere», scrive Simone Weil all’inizio degli appunti che sono raccolti nel volume L’ombra e la grazia. Come nessun altro prima, non ha soltanto descritto questa legge, ma l’ha anche vissuta su di sé. Non si tratta qui soltanto di leggi fisiche: possono infatti trasferirsi anche a livello animico e addirittura spirituale. La forza di gravità è la legge della creazione per eccellenza. Simone Weil la descrive come «un moto discendente». Allo stesso tempo ha luogo una sorta di condensazione, fino al punto in cui il condensarsi raggiunge i suoi stessi limiti. Si origina allora la materia in forma di ciò che è divenuto, di ciò che non può più ulteriormente evolversi e che oppone resistenza. Come una durezza. Una durezza, mediante la quale ci si può destare. Una durezza, mediante la quale ci si può anche ferire.
Quello da “rifugiato” a “migrante” è il passo da una vita dura ma potenzialmente dignitosa a una vita dura e di fatto priva di dignità. Le decine di migliaia di persone bloccate in questa condizione sono derubate del tempo della loro vita – un diritto umano – per opera di un conglomerato di accordi e negoziati. La loro sventura ha superato il limite della spontanea disponibilità a prestar soccorso. Vincolati a un punto senza espansione nello spazio e nel tempo, hanno raggiunto la condizione di non-esistenti.
È sorprendente quanto sia facile guardare e passare oltre. Su queste persone la pesantezza ha portato a termine il proprio lavoro: «Come accade che, non appena un essere umano dimostra di avere, poco o tanto, bisogno di un altro, quest’ultimo si allontana? Pesantezza». (5)
Simone Weil indica con «bassezza» l’effetto della pesantezza e i fenomeni grazie ai quali la si può riconoscere. (6) Il cuore non riesce più a sollevarsi, diventa “pesante”. Nel processo di condensazione c’è dunque un limite dal quale, una volta che è stato superato, non è più possibile tornare indietro. La bassezza inizia proprio dove quel limite è stato oltrepassato. Non si riesce più a trattenersi nell’altezza. Al di sopra di quel limite si potrebbe forse parlare ancora di una certa “indolenza del cuore” – per esempio quando si è talmente presi dalle proprie preoccupazioni personali e dall’autoconservazione, da non riuscire a percepire le sofferenze del prossimo. Al di sotto di quel limite restano soltanto la bassezza, come fenomeno che deriva dagli effetti della pesantezza, e le conseguenze di quella primordiale vulnerabilità propria di ogni essere umano. La caduta è divenuta irreversibile, e porta letteralmente a toccare il fondo. Per Simone Weil questo significa, al contempo, essere caduti al di sotto della pietà. «Una sventura troppo grande mette un essere umano al di sotto della pietà: disgusto, orrore e disprezzo. La pietà scende solo fino a un certo livello e non al di sotto? Come fa la carità a scendere anche al di sotto?» (7)
I moti discendenti, fenomeni della pesantezza, vengono tratteggiati da lei con linee molto semplici – e sorprendono sempre. Per esempio: l’allontanarsi, nel pensiero e nel sentimento, da qualcuno che ha bisogno di te e necessita del tuo aiuto. «Lasciarlo cadere», vien detto in modo molto calzante. Ma è in primo luogo colui che si allontana a finire nella presa di questo moto discendente, e non chi da quello è stato abbandonato a se stesso. Forse un essere umano “abbandonato”, benché umiliato, non per questo entra necessariamente nel dominio della bassezza. Forse egli è ancora capace di carità, perché la carità appartiene alla profondità, non all’altezza. Forse proprio per questo l’essere umano abbandonato e non-esistente è in grado di guardare nella propria profondità.

Piero del Pollaiolo, Carità
Discendere senza pesantezza
Può risultare sorprendente il fatto che sia Rudolf Steiner che Simone Weil mettano in correlazione reciproca la pesantezza e la luce. «La luce irradia verso l’alto, la pesantezza grava verso il basso», recita una frase di Rudolf Steiner dedicata al lavoro di euritmia. È un fatto sorprendente anche perché gli elementi di pesantezza e luce non formano direttamente un’antitesi, e comunque non vengono intesi come opposti. Una coppia di opposti sarebbero luce e tenebra. Onorare la loro peculiarità significa, per esempio, non voler sostituire la tenebra alla pesantezza o non voler superare la pesantezza mediante la luce. Nella splendida rappresentazione che ne dà l’euritmia, si mostra come questi due elementi si condizionino a vicenda senza perdere la loro rispettiva caratteristica. Il gesto relativo all’uno inizia nell’ambito dell’altro: la pesantezza nell’ambito della luce e viceversa. In questo modo si schiude un terzo ambito, un luogo dell’origine, un luogo della potenza creatrice. Al centro, però, per Simone Weil si colloca la domanda se non sarebbe forse possibile discendere verso il basso senza pesantezza. O, viceversa: si può cadere verso l’alto? «La pesantezza fa discendere, l’ala fa salire: quale ala alla seconda potenza [Potenz] può far discendere senza pesantezza?» (8) Quell’ala è la grazia! La grazia, che si rivela in primo luogo come moto ascendente, diventa operante nella seconda potenza. Vale a dire: nel discendere senza pesantezza. La primordiale vulnerabilità, «l’infelicità», e di esse tutte le conseguenze che possiamo incontrare nella vita, ci fanno inermi di fronte alla pesantezza. La grazia non è ciò che compensa la forza di gravità; la grazia diventa invece operante nel moto discendente. La grazia è l’eccezione, perché scende nella profondità senza pesantezza e fa sì che noi, in questa profondità, troviamo il luogo in cui la ferita e il centro dell’essere, la vulnerabilità e la potenza si mostrano in noi come lo stesso e medesimo luogo. «La pesantezza dello spirito ci fa cadere verso l’alto» (9). Noi siamo nella grazia.

Maestro di Rimini, Vesperbild, 1430 circa, Londra, Victoria and Albert Museum
Tra le tue sopracciglia
si trova la tua origine
segno segreto dall’oblio della sabbia.
Le colonne di navigazione
le hai piegate
le hai contorte
nella morsa della nostalgia.
Hai seminato te stesso con i semi di tutti i secondi
fin nell’inaudito.
Le resurrezioni delle tue invisibili primavere
sono lavate di lacrime.
Il cielo esaudisce su di te
frantumazione.
Tu sei nella grazia.
Da: Nelly Sachs, Werke. Band II. Gedichte 1951-1970, Berlin 2010, p. 76.
Note
1 Rudolf Steiner, O.O. 93, 11 novembre 1904.
2 Dalla serie di interviste Aspettare finché non si sente il proprio nome, in De Morgen, agosto 2022.
* N.d.T: in una nota dell’Introduzione al volume citato il traduttore Franco Fortini osserva (p. V): «Quando tradussi questo libro, pubblicato in italiano nel 1951, fui a lungo perplesso per la resa del titolo. In italiano, la pesantezza pesa più della pesanteur; è semmai gravezza, lourdeur. Sarebbe stato meglio “Il peso e la grazia”? […] Ombra, senza dubbio, tradisce la corporeità del sostantivo; spiritualizza, disincarna, è poeticistico. Ma è anche associato al contrasto luce-buio, rivelazione-tenebra. L’ombra è un portato della carne, dice Dante».
3 Simone Weil, L’ombra e la grazia, Bompiani 2002. Traduzione di Franco Fortini, p. 277
4 Ibid. p. 9.
5 Ibid. p. 5.
6 Ibid. p. 5.
7 Ibid. p. 11.
8 Ibid. p. 9.
9 Ibid. p. 9.
